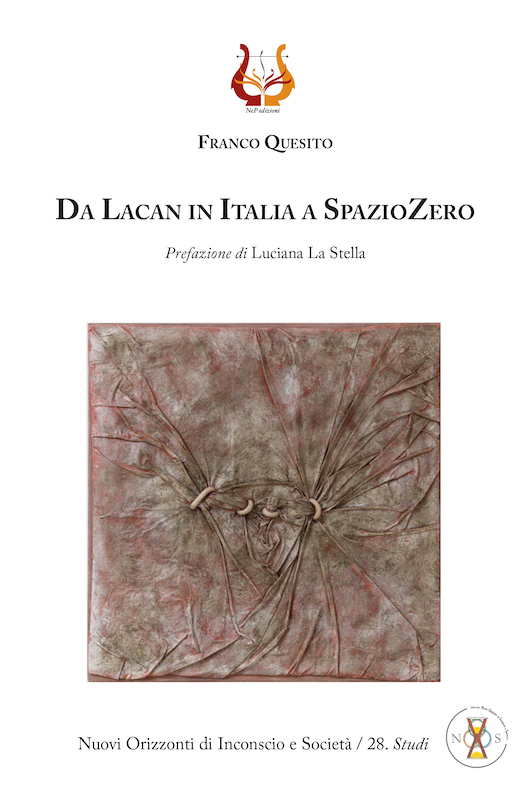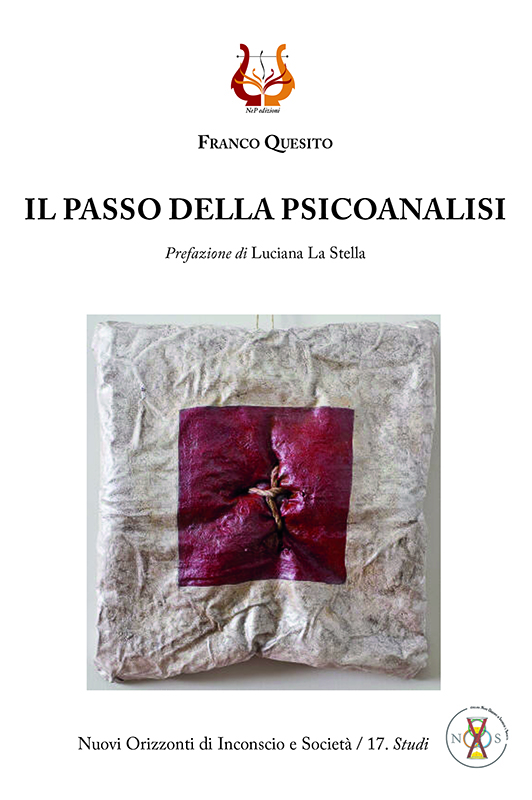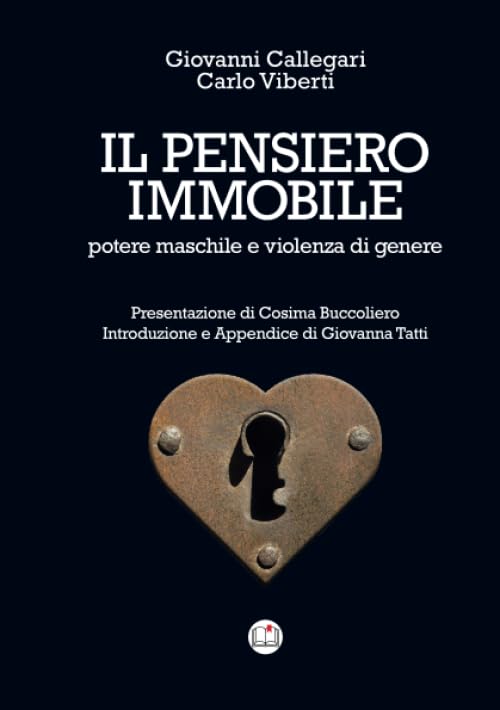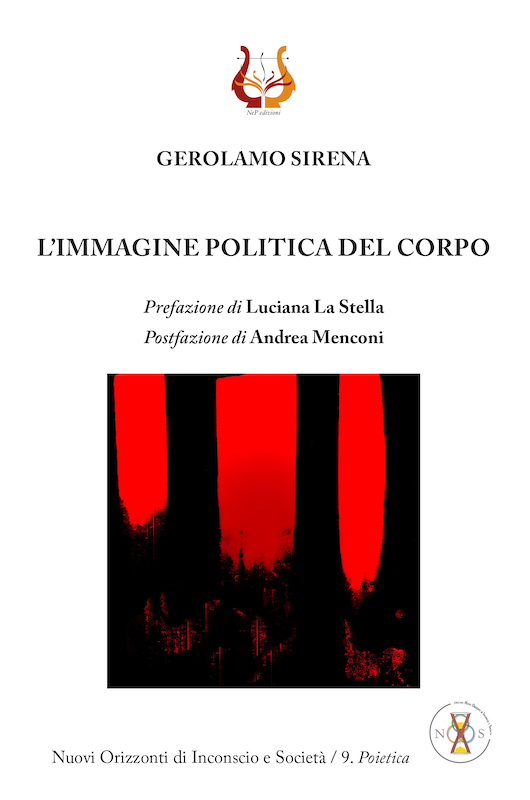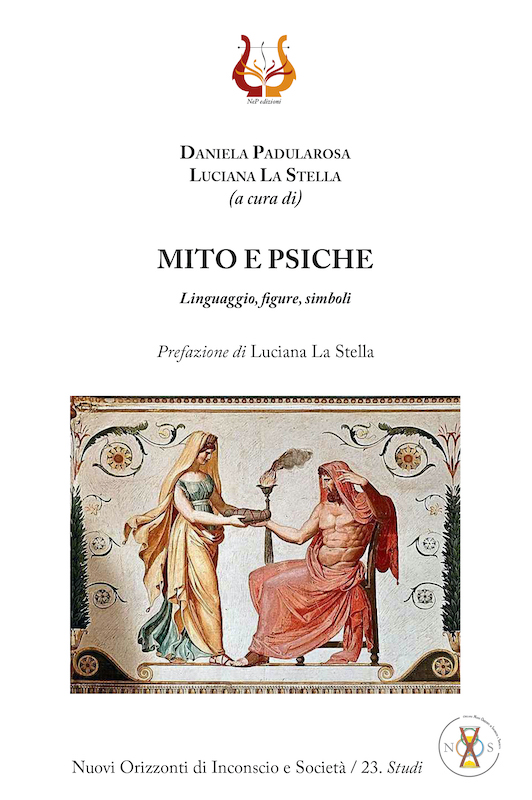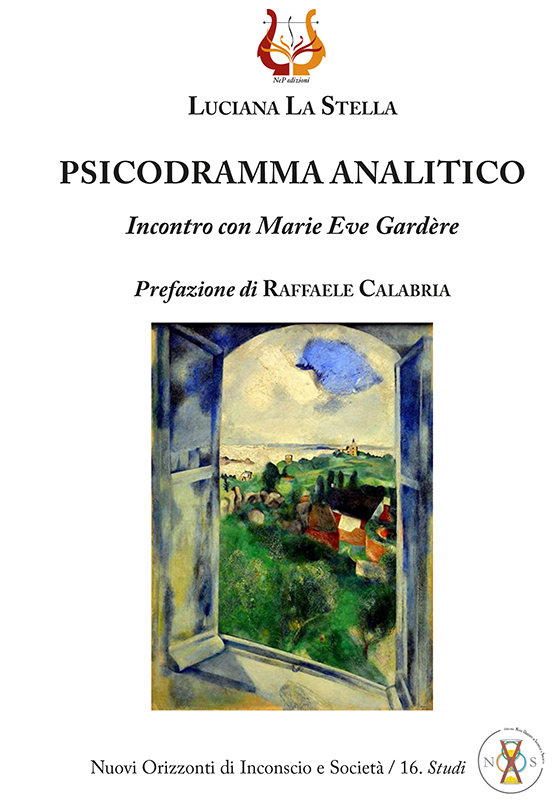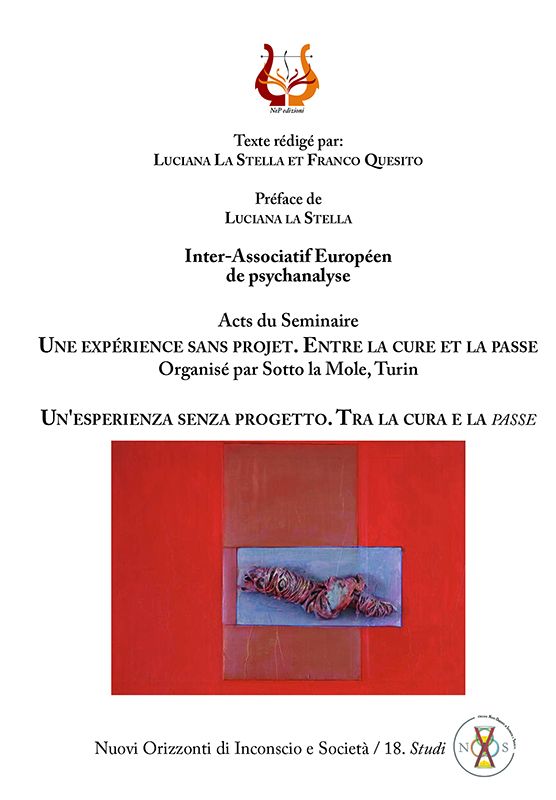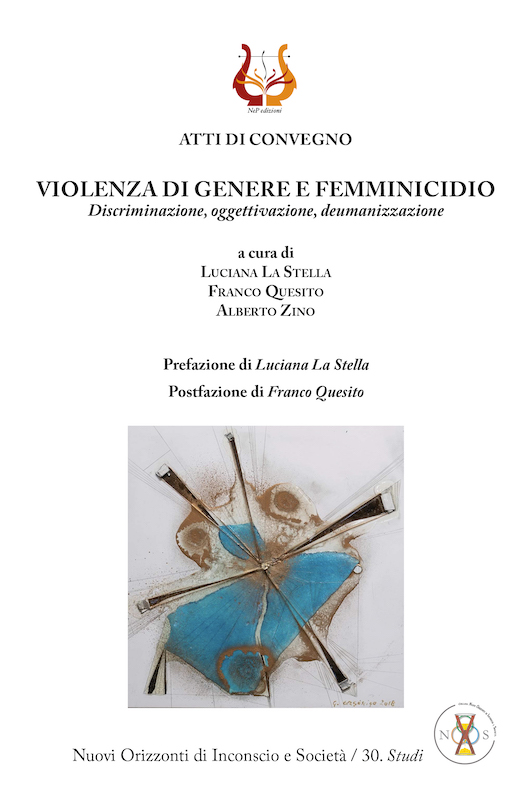Via Baveno 21 bis Torino +39 338-1875103
- Homepsicoanalisi
Clicca qui per l'acquisto Questo libro mette in parola scritta una parte della vicenda della psicoanalisi dell’ultimo trentennio del Novecento italiano. Sono trascorsi pochi anni e quei fatti sembrano essere finiti nella rimozione del cassetto del Novecento ma in quel tempo agirono idee e progetti, proposte e accelerazioni che si sono modificate e infrante, che non hanno saputo dare una continuità a ciò che della psicoanalisi restò solo residuale: la sua laicità, quella rivendicata da Freud nel 1926 in Laienanalyse. Ora non ci resta che diventare degli storici, dei cronisti. Con questa cronaca non intendiamo fissare la storia e legarla a un’epoca oramai trascorsa ma abbiamo l’intenzione di permettere la riapertura di un discorso di ricerca per una psicoanalisi del nuovo millennio. Si tratta di un atto indispensabile per affrontare la nostra contemporaneità senza i pregiudizi di una lettura che tratta il mal d’essere solo come elemento patologico del vivere dell’individuo. La psicoanalisi è nella sua storia, nella costante necessità di reinventare la propria posizione e la propria clinica. Vennero affrontati dalle Commissioni di SpazioZero temi che, tutt’ora attualissimi, sono ancora aperti, come la formazione dell’analista, la nominazione e la sua posizione nella cura. Alcune soluzioni intercorse sino a ora hanno trascurato molti contributi di quei protagonisti di allora che possono essere certamente e doverosamente riscoperti. Farlo potrebbe riaprire questioni teoriche decisamente formative, mentre dimenticarsene non sarà certamente la soluzione delle cose. La nostra contemporaneità nei suoi percorsi sempre più s/travolgenti ci chiama a ritrovare il senso dell’esperienza della psicoanalisi, così come ci ricordava Lacan: Se la psicanalisi può diventare una scienza – dato che non lo è ancora –, e se non deve degenerare nella sua tecnica e forse è già cosa fatta –, dobbiamo ritrovare il senso della sua esperienza.
Clicca qui per l'acquisto Riprendendo la sollecitazione di Lacan, a proposito del leggere Freud, ci sentiamo pienamente coinvolti nell’affrontare il Reale nel registro del Simbolico. La nostra proposta e la nostra lettura prendono il via dalla constatazione che il disagio nella civiltà è un elemento strutturale del rapporto tra il soggetto e il collettivo, un collettivo che si esplicita ovviamente verticalmente lungo tutto il corso della vita e orizzontalmente in ogni situazione di legame sociale. Trattare quindi il mal-d’essere individuale come un fenomeno unicamente del soggetto accettando un’interpretazione unica, quella che lega la persona a una sua posizione sana o patologica come fanno attualmente la Psichiatria e le Psicoterapie, non appare più sufficiente. La nostra contemporaneità, nella sua complessità, stabilisce una situazione nella quale i soggetti si trovano a esprimere la loro struttura di pensiero e di parola, a portare, per così dire, la loro narrazione in atto, in una scena, con il loro stile, ovvero con il loro sintomo. Molti artisti, a più riprese e nei modi i più differenti, hanno reso esplicita questa visione nella loro poetica e noi dobbiamo prendere atto che tanta sensibilità significa altresì capacità descrittiva di un essere umano-parlante in perpetua crisi. La Psicoanalisi non deve sottrarsi a una profonda revisione del suo impegno d’ascolto. Questo libro vuole aprire un percorso in cui la nostra ricerca riprenda pieno diritto di autonomia teorica.
Clicca qui per l'acquisto La serratura a forma di cuore è vecchia, arrugginita, bloccata, non funziona più, non apre più nulla. Vien da chiedersi quale chiave sarà in grado di farci accedere alla sostanza e ai meccanismi dell’amore che la sua forma e il suo uso suggeriscono, forme e usi beninteso culturali. L’allusione è al potere maschile che da sempre, con pervicace intenzione ed esercizio di dominio, pretende di dettare i modi della relazione d’amore o del rapporto tout-court, ma in realtà lo annichilisce, troppo spesso con esiti di violenza e morte. Se c’è potere, non c’è amore. Gli autori indagano i modi in cui tali dinamiche si manifestano nel tempo lungo delle vicende delle donne di ieri e di oggi alle prese con quella scena tragica, attraverso le vicende storiche e le esistenze individuali, il mutare del clima sociale e politico, la tradizione, il costume e la cultura materiale, le narrazioni mediatiche, la fredda evidenza delle cifre, le legislazioni troppo lentamente progressive, le tutele e le istituzioni a loro difesa e sostegno, la mutevole percezione del ruolo della vittima, e poi i loro stessi racconti e quelli di chi su di esse si è accanito nella sopraffazione come unico rimedio all’incapacità del riconoscimento dell’altro. Una rassegna multi-disciplinare di ampio respiro, punteggiata da notazioni e considerazioni cui la psicoanalisi fornisce il suo sapere mite ma netto. Presentazione di Cosima Buccoliero. Introduzione e Appendice di Giovanna Tatti.
Questo libro parla del corpo e siccome la realtà nella quale esistiamo, immaginata, allucinata, delirante, trasognata, declamata, tutelata, trasformata, deturpata e tant’altro, è fatta di corpo, si potrebbe ironicamente dire che questo libro parla del tutto. Il tutto però non è una semplice quantità né una semplice unità (i greci ci erano arrivati agli albori della filosofia), dunque non lo è nemmeno il corpo. Proprio per questo il corpo si fa abitabile ma, come ben aveva suggerito Sigmund Freud, non ne consegue che possa essere governato. Infatti è a volte angosciante prender coscienza che, come nel caso dell’amore, anche al corpo non si comanda. Non che lungo la storia dell’umanità non si sia voluto teorizzare e praticare il contrario, lo stesso concetto di scienza, sorto a beneficio del conoscere, si è adattato a trasformare e a produrre corpo. La robotica, ad esempio, eredita dalla medicina la logica funzionale della partizione corporea per correggerne le carenze strutturali. Una certa ideologia della liberazione a buon mercato, facendo aggio su questa presunta disponibilità, ha realizzato, anticipando le immaginifiche potenzialità della tecnologia, che la stura ad una rivendicazione di pseudo diritti potesse vincolare, nel rispetto del politicamente corretto il corpo all’ hic et nunc del sentir-si. Risultato: le affabulazioni della “cancel culture” importate dagli States.
Con la psicoanalisi invece, il corpo non è più quel corpo, la cui abitabilità diviene immediatamente “occupazione”. Il corpo è tale perché non è mai tutto, non è mai “completo”, manca sempre di qualcosa, anzi è proprio quel qualcosa di cui manca a fare del corpo il luogo primo del diritto (non della rivendicazione di diritti). L’immagine politica del corpo si rivolge proprio a questo resto, a quest’eccedenza, a questa “mancanza” sempre presente e di come con essa e grazie ad essa si scriva la storia di ognuno.
Il volume si propone di trattare due temi strettamente connessi tra loro: la genesi di motivi e figure nell’arte moderna (con particolare riferimento alle avanguardie e alla loro teoria dell’arte) e la mitologia – o la mitologizzazione – del moderno. Il secondo tema consiste nella tendenza da un lato di interpretare l’epoca moderna e i suoi fenomeni artistici attraverso il mito e dall’altro di produrre una mitologia del moderno attraverso un’ibridazione con motivi provenienti dalla tradizione più recente.
Walter Benjamin si confronta con la “mitologia del moderno”. L’ambiguità della sua posizione, più volte evocata, consiste nel suo interesse per la mitologia che in parte utilizza come apparato simbolico e che nel contempo cerca di combattere. Egli conduce infatti una campagna concettuale e metodologica contro un’interpretazione “mitologica” del moderno; Benjamin compie, paradossalmente, un’azione politica proprio quando “discende” nei “sotterranei”, negli spazi del mitico, del “sacro” e del magico: le sue “incursioni” in questi “spazi intermedi” assumono la valenza di una battaglia politico-culturale contro coloro che vogliono interpretare i fenomeni del moderno come “inevitabili” e “inspiegabili”. Nel suo saggio sui Surrealisti e su Aragon, ma soprattutto nel suo Passagen-Werk, Benjamin nega radicalmente la possibilità di interpretare il moderno attraverso il mito. L’approccio antropologico a questo fenomeno è rappresentato anche da una corrente di pensiero scientificamente più fondata con cui Benjamin si è confrontato ripetutamente: Collège de France, Bachofen, Kerényi e, a modo suo, Aby Warburg.
La stessa psicoanalisi (e la già citata antropologia) utilizzano un’iconografica mitologica. Quando Benjamin parla di “gioco”, fa riferimento al gioco verbale dei dadaisti, ma anche al gioco infantile.
La facoltà mimetica del gioco dei bambini, che esprimono l’inconscio, e spesso sono una “distorsione” di un dolore o di un trauma, vanno interpretati alla luce degli scritti di Freud. In Al di là del principio di piacere, infatti, Freud spiega i meccanismi di difesa della psiche – egli parla in realtà di “corteccia celebrale” – nei confronti degli stimoli esterni. In tal modo Benjamin tenta di costruire un sistema euristico in grado di comprendere la modalità in cui vengono percepiti i prodotti artistici del moderno.
Clicca quì per l'acquistoQuesto volume si propone di percorrere le radici della nascita dello psicodramma, a partire dalla sua originaria formulazione di Jacob Levi Moreno e nel considerare l’approccio di Marie Eve Gardère. Una pratica di gruppo, in cui il singolo ha l’opportunità di elaborare suggestioni, vivere la propria esperienza a livello affettivo, catartico, cognitivo ma anche analitico, relazionale e creativo. Lo psicodramma nasce sul versante dell’esistenza, quasi una ribellione al mondo sul versante dell’atto. Interessante l’aspetto repressivo che per Moreno sembra esserne la causa e, in qualche modo, l’origine. Attraversando la sua esperienza si perviene dunque alla matrice neofreudiana dello psicodramma. Lo psicodramma trae la sua originalità dal gioco, dalla spontaneità e dall’analisi che orientata al gruppo. Come in un teatro ma senza scenario né costumi, né testo, si giocano degli istanti di sé, due o tre cose profondamente legate al corpo e all’inconscio, sorte lì all’insaputa dei protagonisti, si potrebbe dire senza che se ne accorgano. Fanno da sfondo all’intera trama due incontri da una parte l’autrice: con lo psicodramma, che ha integrato la sua formazione e il suo orientamento lavorativo e dall’altra, l’incontro con Marie Eve Gardère, psicologa-psicoterapeuta che ha messo in evidenza la duttilità dello psicodramma, la sua adattabilità alle situazioni sociali e professionali diverse. Il libro intreccia tecnica, teoria, narrazione, immagine e poesia. Porta a sintesi il lavoro analitico che dalla teoria accede alla pratica. Si propone come valido riferimento teorico e pratico grazie alla trasmissione metodica di un sapere analitico sullo psicodramma nell’esperienza gruppale, intessendo una reciprocità dei rapporti nel tempo.
Nella parte finale del testo è stato possibile inserire talune interviste condotte da Marie Eve Gardère con personaggi testimoni della contemporaneità nella multidisciplinarietà del loro sapere.
Clicca qui per l'acquisto Il seminario Tra la cura e la passe. Un’esperienza senza progetto arriva dopo il seminario I-AEP A Reinvented Pass di dicembre 2019 e vuole esserne l’ideale prosecuzione. Tra la cura e la passe c'è un'analisi, dall'inizio – cioè qual è l'approccio all'ascolto e la domanda dell'interlocutore – fino a una possibile fine, che non arriva necessariamente ad assumere la posizione dello psicoanalista seduto in poltrona, ma anche quella di coniugare la propria vita con un'altra competenza di sé.
Discriminazione, oggettivazione, deumanizzazione
La testimonianza che la psicoanalisi può dare dell’essere, l’unico spettatore di una rappresentazione tragica del dolore umano, implica che qualcosa di ciò si sposti dal ruolo dello psicoanalista e del terapeuta, che cura lo psichico ritenuto malato, per diventare la persona che ne ascolta il dolore dell’anima per tradurre in una nuova consapevolezza le ferite e il diritto di essere sé, senza alternative e/o dubbio alcuno. Un titolo che attraversa la nostra contemporaneità non solo come cittadini italiani o europei, ma come attraversatori di mondo. Una curamondo che ci convoca e in cui abbiamo consegnato il nostro sapere teorico e clinico. Ogni invito alla parola aggiunge consapevolezza e punti ulteriori per procedere nel ri/cercare quanto sia insito in ogni storia personale, la quale porta in sé sempre qualcosa di nuovo, che vivifica l’ascolto, attento e solidale, che ogni psicoanalista mette nel setting e nella relazione intersoggettiva. In ogni pagina degli atti il lettore avverte una propria implicazione che può essere approfondita al fine di trovare l’ampiezza e la profondità dell’essere che è in grado di affrontare le proprie difficoltà di vivere, ovvero il proprio mal d’essere alla luce di tante sfumature, e trova un diverso senso e significato, al di là del percorso personale.